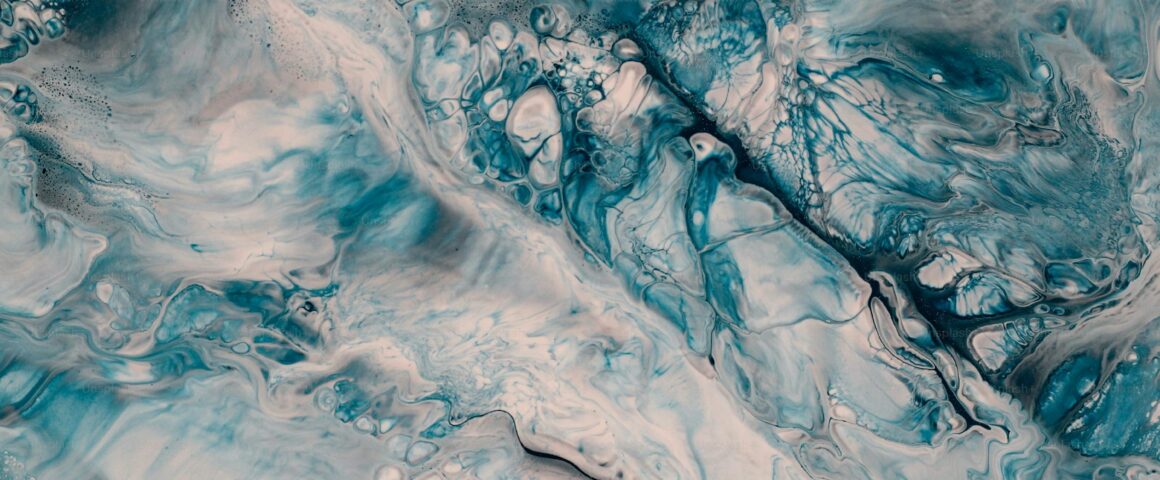Nel titolo dell’ultima opera di Kant, Antropologia pragmatica, non è occultata alcuna improba filosofia né essa rimanda a scabre metafisiche, ad astratte teoretiche o meditazioni trascendentali. Così, nella Prefazione all’opera, il filosofo di Königsberg disarma il lettore sia per la plasticità del pensiero sia per la sua immediata leggibilità. Qui si legge che l’antropologia pragmatica, da un lato riguarda l’«uomo», dall’altro qualcosa a esso intrinseco, quel che l’uomo «fa di sé stesso o di ciò che egli può e deve fare di sé stesso». Secondo un’altra definizione kantiana, letta nel paragrafo Del gusto nell’arte, l’Antropologia è anche il luogo «dove si cerca di conoscere l’uomo secondo ciò che si può fare di lui».
Il momento cosiddetto pragmatico dell’Antropologia impone dunque sia uno sguardo diretto sulla realtà umana, concepita come sua azione nel mondo, sia una qualificazione del mondo, della totalità del mondo a partire dal suo «oggetto» esemplare, l’uomo come «cittadino del mondo», l’uomo concepito come agente di progresso individuale. In altre parole, Kant opera entro l’orizzonte umano dell’umanità, in una sfera ‘fisica’ dell’uomo, al punto che l’Antropologia, figurando alla stregua di un vademecum di carattere autotelico, è oltretutto «esposta in forma popolare» cosicché ogni uomo, «ogni lettore può comprendere» l’identità e il senso di un pensiero che potrà riguardarlo.
Per Kant, l’uomo è un legno storto (Idea per una storia universale, 1784). Intorno a questa cognizione dominante, nell’Antropologia, che è del 1798, è percorsa una lunga e articolata via analitica. Essa inizia nel luogo in cui l’uomo è più uomo, l’elettivo luogo dell’«egoismo» umano posto in contrapposizione al cosiddetto «pluralismo», la condizione che dell’uomo fa appunto un «cittadino del mondo». Da ciò emerge un primo elemento di valutazione, qualcosa che idealmente rifluisce da un conatus leibniziano. Esso riguarda, in specie, la nozione di espansione come attributo dell’umanità felice. Al contrario, gli opposti casi di contrazione, quali ad esempio l’essere più capaci di «attenzione» puntuale, meno di aperta «astrazione», di affidarsi alla «sensibilità», per Kant la «facoltà “inferiore” di conoscere», più che alla superiorità dell’«intelletto», nell’uomo segnalano la presenza di uno stato di imperfezione. L’uomo cioè statuisce in sé, si statuisce come un errore. «In quale puerilità non cade l’uomo nella sua età matura quando si lascia condurre al laccio della sensibilità!» scrive Kant in un passaggio dell’Antropologia.
L’imperfezione non emerge tanto dai limiti naturali della «sensibilità», dall’esteriorità dei «sensi», quanto dal cosiddetto «senso interno» all’uomo. Così per «senso interno», Kant intende la «coscienza di ciò che egli patisce, in quanto è affetto dal gioco dei suoi propri pensieri». Pensare, dunque, è un potenziale, e spesso il reale innesco dell’infelicità umana. Scrivendo Kant che l’«illusione è allora esaltazione o anche visione, e sia l’una che l’altra un inganno del senso interno», fissa l’attenzione speculativa sul grande tema dell’infelicità individuale. Essa è interpretata come atto di produzione, essendo individuata, oltretutto, come realtà interna dell’uomo, cioè come effetto di una causa nata nel soggetto e da esso emanante. L’«inclinazione a illudersi», scrive Alberto Tettamanti nell’Introduzione all’Antropologia (Armando, 2025), vale dunque l’istituzione di un paradigma negativo, qualcosa che della produzione fa un fenomeno che si genera, una forza che rovinosamente ricade sul soggetto.
Il tracciato di una siffatta via negationis conduce al tema dell’«immaginazione». Essa stessa è un’«illusione», e come il «senso interno», nella sua attitudine a tradire il soggetto, è foriera di uno sviamento. L’uomo allora «crede di vedere e di avvertire fuori di sé cose che esistono soltanto nella sua mente», e vi crede come accade a chi abbia l’esperienza sentimentale, emotiva della nostalgia. L’esistenza di una malattia del ritorno, in sé è un controsenso, poiché la cognizione di ritorno non impone l’approdo a un luogo geografico, ma vivendo un tale sentimento, in realtà l’uomo anela a recuperare un luogo dell’anima, sia esso la giovinezza, la fanciullezza o altro. Insomma, in tale caso l’uomo si ostina a voler rivivere ciò che è perduto per sempre. Sulla nozione di inessenza, sulla pura fantasticheria come «curas hominum!», Kant intesse un discorso opposto al passato come luogo di speculazione: il futuro. In tale modo, il di qua come il di là del presente, per il filosofo dell’Antropologia divengono luoghi di verifica, prospettive cioè di una medesima aberrazione nonché testimonianze sulla natura obliqua e asimmetrica dell’umano. Quella, per intenderci, avulsa dall’hic et nunc, estranea a quell’idea radicale dell’essere e del suo più vero fondamento. L’essere allora è disperso nello spazio esistenziale, nel tempo regressivo della memoria o in quello prospettico dell’avvenire.
Quando Kant elenca un «intelletto giusto, un giudizio esercitato e una ragione profonda», il luogo di verità, cioè la prediletta area di meditazione ‘pragmatica’, è la prassi intellettuale. Entro tale alveo, un problema come quello del male, o meglio della «malizia» o dello «spirito di intrigo», per Kant «non è una forma raffinata di intelletto ma un modo di pensare di uomini assai limitati». In altre parole, le fisionomie del male umano esprimono soltanto l’«apparenza» di una forma di intelligenza. Così «esigere dall’uomo la saggezza», una sapienza ideale al di là del limite umano, assume la qualificazione di ‘mito’, e ciò perché lo sviluppo di un’intelligenza entro il solco della «legge morale», in termini di umanità, così scrive Kant, è come «chiedere troppo» a ogni uomo. Invece, al di sotto di un ideale livello di saggezza, cioè di quel virtuoso rapporto tra l’intelligenza e l’etica, l’etica sociale ma soprattutto l’etica individuale, Kant elenca una sequenza articolata di ‘tipi’ umani, una galleria ‘antropologica’ di umanità imperfette, appunto una sequenza tipologica tesa a individuare, nella varietà della specie, appunto la costante presenza di un errore. Qui il filosofo coglie una continua, perdurante e inguaribile malattia dell’anima umana, la condizione stessa per intuire i salienti di quella che si definisce la «degradazione dell’essere umano». E sebbene Kant dedichi pagine luminose così al talento come al genio umano, nell’Antropologia ritorna sempre, e nella maniera di un perdurante assillo speculativo, allo «stato di minorità» dell’Aufklärung, il cui momento più aurorale non è più l’immagine di un uomo condotto, un uomo che va condotto, ma uno che finalmente si conduce da sé, autonomo nella scabra scena della vita.
Quando Kant affronta i temi del piacere e del dolore, la tesi che «senza dolore la vita cesserebbe», da un lato ammette comunque la sua alternata presenza con il piacere, dall’altro tuttavia ne fa una condizione umana inestirpabile. Il dolore infatti è il «pungolo dell’attività», il seme vivo dell’idea di «progresso». Ma ciò che più caratterizza l’essere umano è altro: l’uomo quale soggetto desiderante senza oggetto del desiderio. Una tale testimonianza di «minorità» riflette dunque un anelare privo di orizzonte, del tutto ateleologico. Anche quando il desiderio si incarna e dura, nel caso della passione, l’uomo appassionato è un uomo ‘malato’, un essere inguaribile. Le brame di «onore, di dominio e di possesso», cioè le passioni secondo la minima classificazione di Kant, sono peculiari dell’uomo, anzi appaiono entro il loro naturale quadro sociologico, cioè le «inclinazioni di un uomo verso un altro uomo». Ora, nel pensiero kantiano la nozione di passione come brama, il πόθος di matrice greca, coinvolgendo l’uomo, poiché immesso nel consesso degli uomini, in realtà rivela in lui l’emblema della «vittima», il simbolo stesso di un’occulta «debolezza», il paradigma di una pericolosa «condizione di schiavitù». La passione dell’onore, infatti, genera «odio», quella del dominio produce «paura» e quella del possesso alimenta il «disprezzo».
Il moralista Kant, in realtà, elabora un sistema antropologico-pragmatico teso a configurare, a esporre una legge, a descrivere l’uomo per interpretarlo alla luce di se stesso, cioè fissando – quasi alla maniera di Montaigne – la sua natura e la sua cultura, il centro e i margini di una totalità direttamente acquisita nell’osservazione sul campo. Essa non figura soltanto una critica di base ‘pratica’ tesa a individuare la formula generale del ‘fenomeno’ umano. Nell’uomo, nella sua azione mondana, lo stato di imperfezione perdura e fiorisce nella luce cupa dell’aberrazione, in un errore di valutazione soggettiva scambiata, anzi erroneamente intesa nel suo valore oggettivo. Allora, riprendendo la nozione di «senso interno», la fallacia del metodo e l’interpretazione soggettiva riguardano anche la menzionata «illusione», cioè il dato reale trasfigurato in irrealtà immaginaria. E l’illusione, quando essa esprime un’utopia inscritta nello spazio del reale, un vulnus nel cuore della realtà, in certa maniera restituisce un’immagine persino positiva dell’umanità. A proposito della «pigrizia», della «viltà» e della «falsità», per Kant «tre vizi», ancorché indicativi di uno stato di imperfezione, possono assumere una funzione di tipo salvifico, poiché si adempiono in forme di inazione virtuosa, e per così dire soteriologica. Così, senza la pigrizia l’«infaticabile malvagità umana avrebbe causato nel mondo molto più male di quanto ne abbia fatto finora», senza la viltà la «sete di sangue e le guerre avrebbero ben presto sterminato l’intero genere umano», senza la falsità la stessa «malvagità insita nella natura umana avrebbe già mandato in rovina interi Stati».
Quando Kant scrive del «temperamento» dell’uomo nell’ambito della sua «caratteristica antropologica», in altre parole del suo «carattere» secondo il tradizionale modello greco di Teofrasto, in realtà scavalca il problema riguardante la «qualità del sangue» favorendo la «combinazione dei sentimenti e delle inclinazioni che si osservano in lui». Se il carattere è «cosa rara, che suscita rispetto e ammirazione», escludendo Kant il tema relativo a quel che la «natura fa dell’uomo», a costituire un elemento di distinzione esemplare è l’idea, peraltro già introdotta dal filosofo come misura esemplare della speculazione, l’idea appunto di «ciò che l’uomo fa di sé stesso».
Così, lo status quo della specie umana, il «seme della discordia», discusso da Kant anche in Idea per una storia universale, è il seme marcio di quella conflittualità ‘naturale’ dalla quale l’uomo anela a divenire altro, anzi l’uomo è sempre nella condizione di anelare, all’alterità della «concordia». Essa può determinarsi attraverso l’azione umanizzante della «cultura». Per Kant, dunque, l’«uomo devia costantemente dalla sua destinazione», opera cioè secondo un modello antropologico fondato sulla dialettica metaforica tra progressive ‘cadute’ e costanti riprese del cammino lungo la via orientata della vita, transita cioè lungo un crinale etico in cui la cultura costituisce una possibilità, forse l’unica possibilità.
A differenza dello scetticismo rivelato da George Steiner in Linguaggio e silenzio, in cui la sanguinosa storia del Novecento si incarica di separare violentemente il nesso virtuoso di cultura ed etica, all’alba della modernità, proprio alla cultura Kant affida una possibilità, l’unica per la formazione di un’identità etica nell’uomo. Una possibilità cui però è richiesta una disponibilità a essere, e dunque l’idea che anche ciò che è un legno storto, come si legge nella «sesta tesi» dell’Idea per una storia universale, potrà ambire ad approssimarsi, non a essere, e dunque a rincorrere l’immagine di sé come un legno invece «diritto».